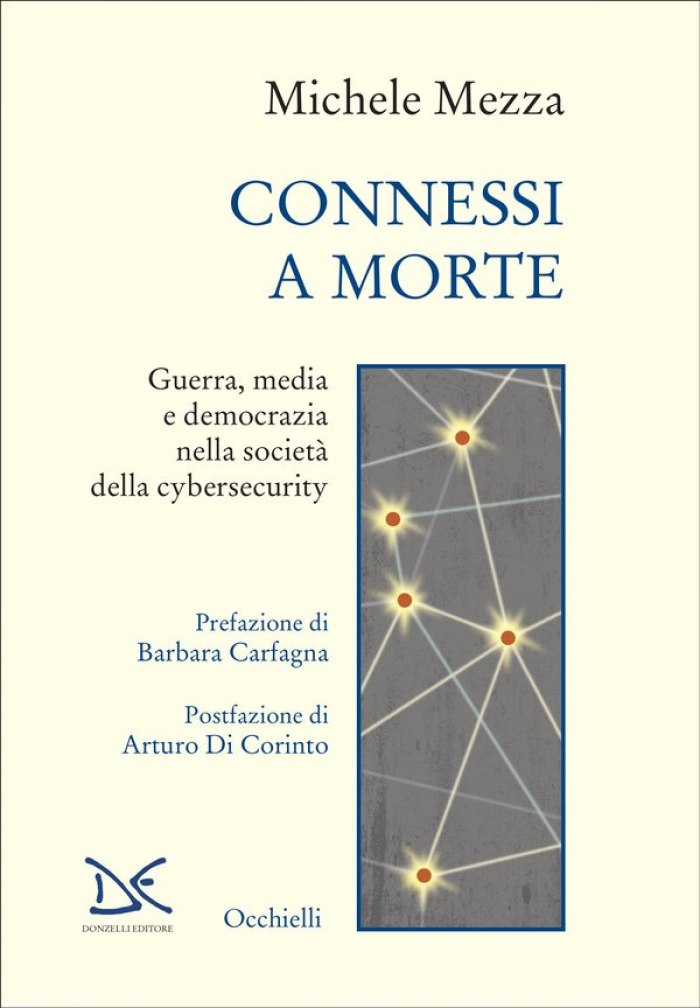
Diana Daneluz
Connessi a morte. Un titolo molto forte per un’opera che con forza prende di petto la tecnologia, una tecnologia omicida in campo militare, dove i proiettili hanno nome e cognome. Di lì il discorso si allarga ad un tema da sempre caro all’Autore, su cui non si stanca di sollecitare riflessione critica e confronto: la doverosa negoziabilità sociale dell’algoritmo.
A due anni da “Net-war. Ucraina: come il giornalismo sta cambiando la guerra” – dove Michele Mezza raccontava di un cambiamento epocale nel giornalismo nel rapporto tra redazione e fonti, e con competenze tecnologiche che tendono a soverchiare il giornalista trasformandolo in un funzionario del sistema di calcolo, una mediamorfosi che trasforma guerra e giornalismo in una contesa matematica –, e con il conflitto di sfondo a quel volume ancora tragicamente in corso, è uscito in questi giorni il nuovo libro dell’Autore, “CONNESSI A MORTE. Guerra, media e democrazia nella società della cybersecurity”.
Pubblicato da Donzelli Editore nella collana Occhielli, in poco meno di duecento pagine coglie uno dei passaggi fondanti della odierna società digitale: i vincitori usano i corpi dei vinti non per confermarne la morte, ma per certificare la vulnerabilità dei vivi. Il concept del libro di questo scrittore che resta soprattutto un giornalista-cronista nasce dalla osservazione della più stretta attualità, dalla manomissione dei cercapersone di Hezbollah alla pianificazione chirurgica con l’Intelligenza Artificiale dei bombardamenti a Gaza fino alla campagna elettorale di Trump e Musk. “Attuale come un magazine, approfondito come un saggio” è infatti lo slogan coniato dall’editore all’uscita del libro, a sottolinearne il correre sulla cresta dell’onda di questo complesso presente che, come sempre, Michele Mezza non si accontenta di osservare, ma sente il dovere di contribuire ad interpretare.
I due lati della Cybersecurity
Il cuore del ragionamento di Mezza è la scoperta che fra guerra e pace la cerniera è la cybersecurity. La difesa e la manomissione di quella materia “viva”, di quell’arma propria che è lo scambio di contenuti e informazione online sta diventando oggi l’oggetto e il soggetto sia della guerra, del modo in cui si organizza il combattimento, sia di quello spazio che intercorre tra le guerre che, dice Mezza, “noi ci ostiniamo a chiamare Pace”. E in questo processo di trasformazione, di mediamorfosi, cambiano i profili professionali e le attività, dai generali ai giornalisti, dagli imprenditori ai pubblici amministratori: tutto diventa da un lato – spiega l’Autore – tecnicalità di difesa della propria integrità digitale, e dall’altro tutto diventa capacità di intromissione. La difesa dei patrimoni cognitivi digitali diventa prioritaria in una guerra che oggi è una guerra individuale, in cui a contrapporsi non sono più due masse anonime, ma due moltitudini di profili individuali, conoscibili e riconoscibili attraverso l’analisi dei dati, in cui ciascuno guarda in faccia il suo nemico e pianifica la sua eliminazione. Una guerra dove si vince interferendo
Altro aspetto della cybersecurity è quello semantico, che tocca più da vicino gli analisti e i giornalisti, l’alterazione sistematica e industriale delle fonti. Oggi non ci sarebbero più fatti, ma solo interpretazioni e alla luce di questa consapevolezza, se condivisa, si comprenderebbe meglio la dinamica politico-elettorale americana sfociata nella vittoria di Trump, con un Elon Musk, ad di Tesla, ammonisce Mezza, “assunto a sommo sacerdote del governo, un sacerdote la cui regola, dichiarata ed esplicitata, è quella di sostituire i dati alle regole”.
Lo Stato intelligente
L’osservazione di Mezza si dipana nel testo sia attraverso l’analisi degli scacchieri di guerra sia del mondo del giornalismo, ma anche del cd. “Stato intelligente”, quel processo per cui le risorse di intelligenze artificiali sono da alcuni mesi in via di integrazione all’interno degli apparati statali. Ma qui sorgono altre domande: chi è il fornitore di queste intelligenze che permettono poi allo Stato e ai suoi apparati di fare delle scelte piuttosto che altre? Quale livello di trasparenza, di pubblicità, ci è consentito?
Questa la scaletta dei temi principali che il libro propone, con l’assist prezioso offerto dai contenuti della prefazione di Barbara Carfagna, conduttrice di Codice, l’unica trasmissione del servizio pubblico ad occuparsi di divulgazione scientifica, ma anche sociale, sul Digitale e l’Intelligenza Artificiale, e di Arturo Di Corinto, responsabile della comunicazione dell’Agenzia nazionale per la Cybersecurity. Ma molte di più sono le sollecitazioni che l’Autore pone al lettore, invitandolo a porre attenzione anche a possibili storture nella gestione pubblica delle sperimentazioni dell’IA in corso, ad esempio nella scuola dell’obbligo, e più in generale nell’uso delle risorse di IA in tutti gli ambiti, anche delicatissimi come quello dell’istruzione, della cultura, della salute, e il tutto verso la costruzione di strumenti sovranazionali di narrazione ammaliante che conquista, cambia le regole del gioco, e il tutto al di fuori di ogni controllo democratico.
Il nocciolo della questione e la “terza gamba”
C’è un messaggio positivo in fondo ai quattro capitoli del libro? No. Ma c’è, una volta di più, la sua call to action. “È la prima volta nella Storia”, ricorda e ammonisce Mezza, “che una tecnologia non viene socialmente negoziata, da grandi correnti d’opinione così come da minoranze attive”. L’Autore torna di nuovo sul nocciolo della questione che in successivi suoi libri ha cercato di porre al centro dell’attenzione: “Come si negozia l’algoritmo? Chi sono i soggetti negoziali? Come si mette a tavola una controparte e la si costringe aprire la scatola nera?”. Qualcosa si sta muovendo, ammette Mezza. E qui deve dare merito al Presidente degli Stati Uniti Biden di aver fissato, con la firma del suo ordine sull’Intelligenza Artificiale, due passaggi fondamentali: primo, i dati sono beni comune e come tale io, Stato, ho titolo a metterci mano. Secondo, l’Intelligenza Artificiale non è di proprietà di qualcuno. Gli effetti, i singoli servizi possono essere proposti da singole aziende, ma i sistemi, i codici sorgente sono l’evoluzione di un general intellect, non è roba privata e come tale da questo punto di vista va socialmente gestita. Tuttavia, Mezza fa un passo in più nel ragionamento. Secondo lui gli Stati non sono soggetti abilitanti, perché lo Stato rischia di essere un elemento che si sostituisce al dominio del privato, con un titolo maggiore della proprietà, che è la rappresentanza, ma con un rischio di distorsione sul terreno dei poteri.
Per Mezza, sarebbe necessaria “una terza gamba al tavolo”, quella di una “negoziabilità sociale”, in grado di civilizzare la potenza straordinaria del Digitale. Quanto ai soggetti che potrebbero costituire questa terza gamba Mezza fa delle ipotesi nel libro. Per esempio, la grande città, con la sua capacità di spostare ricchezza dall’ambito pubblico all’ambito privato, la smart city con i servizi forniti alla comunità locale ad esempio attraverso Google, è un terreno di possibile negoziazione, a patto che ci siano gruppi, associazioni, movimento che sollecitino questa civilizzazione del digitale. Puntando al vero punto centrale che è quello dell’addestramento dei sistemi di IA. È lì che si gioca la partita fondamentale, per cui governare questi processi da parte di organismi comunitari diventa altrettanto fondamentale. Anche le università potrebbero essere soggetti negoziali e così le grandi categorie professionali, ad esempio sulla sanità. Dopo di che, conclude Mezza per ora, il mondo del lavoro, le infrastrutture politiche, le istituzioni “devono saper orchestrare queste capacità negoziali”. Si impone una strategia corale “a cui progressivamente i singoli operatori possano dare forma e carattere senza dover subire domini o vincoli”. “Perché questo è un mondo che va reso vivo e per tutti, un mondo dove al momento hanno voce solo i proprietari. E questo non è accettabile”.
Una cassetta degli attrezzi
Subito prima della postfazione, l’Autore regala, come è solito fare, al lettore la sua “cassetta degli attrezzi”. Nessuna risposta preconfezionata, sta parlando ad un Lettore, appunto. Ma un percorso di letture ulteriori che personalmente sono quelle che lo hanno ispirato per i diversificati capi del filo del suo ragionamento, un ragionamento che mai come sugli accadimenti e processi in corso su cui è condotto, deve ulteriormente dipanarsi. Tra i suggerimenti, due riguardano la Storia della Comunicazione. Val la pena citarli qui: Didattica dell’Illuminismo di Max Horkheimer e Theodor Wiesengrund Adorno, per le sue intuizioni sulle gerarchie sociali, e Culture Analytics di Lev Manovich, catalogo contemporaneo sulla creatività dell’algoritmo.
L’Autore
Michele Mezza, giornalista, saggista e docente universitario. Una lunga carriera in Rai, prima ck e inviato all’estero (Urss e Cina) poi come responsabile di sviluppo di progetti tecnologici. Fra l’altro ha ideato e realizzato il progetto del primo canale All News della Rai, Rainews2. Insegna epidemiologia sociale presso l’Università Federico II di Napoli. Collabora con testate e blog, fra cui Huffington Post. Dirige la comunità digitale Mediasenzamediatori.org. Ha scritto vari libri fra cui, per l’editore Donzelli, Avevamo la Luna (2013), Algoritmi di Libertà (2016), Il contagio dell’Algoritmo (2020) Caccia al Virus, con Andrea Crisanti, nel 2021; ed infine, Net War (2022). CONNESSI A MORTE (2024) è il suo ultimo libro.
Connessi a morte
Guerra, media e democrazia nella società della cybersecurity
Michele Mezza
Prefazione di Barbara Carfagna
Postfazione di Arturo Di CorintoEditore
Donzelli Editore, 2024
pp. 184