
Veronica Boldrin
Questa prima intervista segna l’inizio di un ciclo di cinque appuntamenti a cura di Veronica Boldrin, che, con cadenza quindicinale, ci guideranno, insieme a Silvia Brena, nell’esplorazione e analisi di alcune parole chiave per il mondo della comunicazione.
Silvia Brena rientra nella categoria delle persone magnetiche. Lei parla, tu la ascolti. E vorresti che non smettesse mai. Non solo per la sua storia avvincente, ma anche per la straordinaria capacità narrativa con la quale, parola dopo parola, ti accompagna nel viaggio del suo racconto. E delle parole, Silvia Brena, è una profonda conoscitrice.
Scrittrice e giornalista, ha contribuito a ridefinire - con una visione lungimirante e una strategia innovativa -, il panorama delle testate giornalistiche femminili italiane come Io Donna, Cosmopolitan - di cui è stata la prima direttrice- e Donna Moderna, dove ha ricoperto ruoli di rilievo.
È CEO dell’agenzia Network Comunicazione, creata nel 2004, conosciuta per aver lanciato in Italia il progetto di Dove contro gli stereotipi di bellezza.
Ha fondato, insieme alla costituzionalista Marilisa D’Amico, VOX – Osservatorio italiano sui diritti, ed è membro del coordinamento della Rete nazionale contro i discorsi e i fenomeni di odio, che riunisce le realtà più attive nella mappatura, prevenzione e contrasto dell’hate speech.
A ottobre 2024 Silvia Brena ha pubblicato Parole in Tempesta. Dizionario della Contemporaneità, un viaggio tra la superficie e la profondità della nostra lingua, alla scoperta dei significati nascosti nelle parole che usiamo ogni giorno. Un’analisi profonda ed emozionante che si sviluppa attraverso la voce dei protagonisti di storie dei nostri giorni.
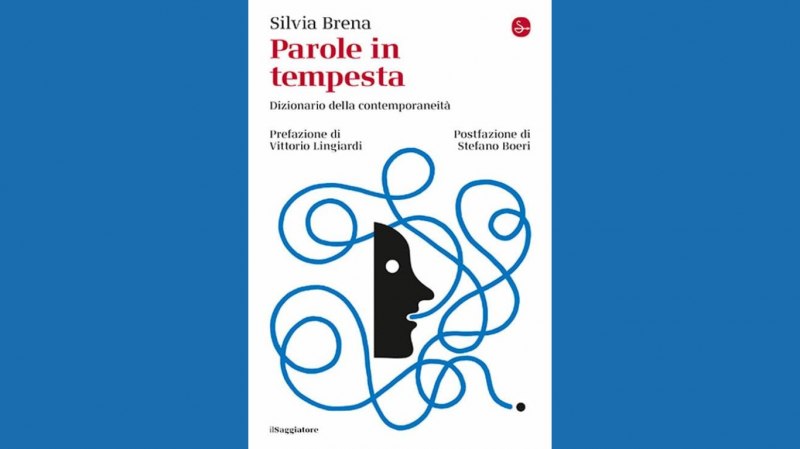
Dalle pagine del libro di Silvia Brena emerge un messaggio chiaro: in un’epoca in cui la comunicazione si frammenta tra piattaforme digitali, social media e nuove forme di interazione, il linguaggio si rivela uno strumento ancora più potente e sfidante, soprattutto per chi, delle parole, ne fa un mestiere, come giornalisti e comunicatori.
Questa prima intervista segna l’inizio di un ciclo di cinque appuntamenti che, con cadenza quindicinale, ci guideranno, insieme a Silvia Brena, nell’esplorazione e analisi di alcune parole chiave per il mondo della comunicazione.
Silvia, qual è la sfida più grande per i comunicatori di oggi nell’uso del linguaggio?
Oggi la sfida più grande per chi lavora nella comunicazione è quella di utilizzare un linguaggio ricco, variegato e onesto, capace di fotografare realmente quello che si vuole descrivere senza appiattirlo o distorcerlo, dando spazio all’ascolto e rispettando le opinioni di chi ci legge.
Si tratta di abbandonare il sensazionalismo che per anni ha dominato la narrazione, senza però cadere in un linguaggio privo di impatto. La chiave sta nella coerenza e nell’appropriatezza delle parole, scegliendole con cura per restituire un messaggio chiaro, incisivo e rispettoso della realtà che si vuole raccontare.
Con l’avvento del digitale le parole vengono spesso semplificate, ridotte o distorte. Come possiamo bilanciare precisione e immediatezza nella comunicazione contemporanea?
L’avvento del digitale ha portato a una contrazione del linguaggio: basti pensare a come scriviamo sui social, WhatsApp o persino nelle e-mail. Questa abitudine finisce per incidere sulla nostra capacità di esprimere pensieri complessi e di valorizzare la ricchezza lessicale dell’italiano, che è una lingua molto bella, ma anche articolata e non di facile percezione, che mal si presta alla sintesi imposta dalle piattaforme digitali.
Risulta quindi fondamentale preservare la varietà e la profondità delle parole che scegliamo, perché l’eccessiva semplificazione non solo appiattisce il discorso, ma distorce anche il pensiero. Il digitale, per sua natura, tende a eliminare le sfumature, riducendo tutto a una logica binaria, bianco o nero, positivo o negativo. Questa è una postura mentale pericolosissima dato che alimenta una visione della realtà polarizzata e semplificata, Oggi più che mai dobbiamo difendere la complessità del linguaggio, perché è attraverso le parole che possiamo contrastare una narrazione rigida e divisiva.
Nel tuo libro parli delle parole come "ponti". Cosa significa?
Le parole sono ponti perché trasportano significati profondi, radicati nella nostra storia e capaci di orientare il futuro. Nel mio libro ne ho scelte nove, parole del lessico comune ma allo stesso tempo dotate di una carca energetica fortissima. Parole come abuso – parola a sua volta molto abusata -, verità, parola importantissima, bellezza, cura, identità, memoria, natura, morte, dolore (e paura). Sono parole portatrici di un senso profondo che definiscono il nostro essere sociale in questo momento storico.
Non essendo una linguista, ho costruito il libro attraverso testimonianze di chi vive queste parole nel proprio quotidiano. Ad esempio, un medico di pronto soccorso che ha affrontato il Covid in prima linea per morte, per natura la delfinologa del MIT che ha scoperto per prima il linguaggio delle mamme delfino, una sorta di lallazione simile a quella che usiamo noi umani.
La capacità di queste parole di “fare da ponte” consente di abbattere barriere comunicative e di stimolare una riflessione più profonda sul linguaggio e sul suo ruolo nel plasmare il pensiero collettivo. Certe parole, grazie alla loro elasticità semantica e alla loro carica simbolica, possano contribuire a creare connessioni in grado di arricchire il discorso pubblico e a rendere il linguaggio uno strumento di mediazione e innovazione culturale.
La parola verità, ad esempio, impatta direttamente anche con il mestiere di chi comunica e con tutto il tema, oggi importantissimo, dell'intelligenza artificiale, delle fake news. La parola verità come parola ponte, si porta appresso altre parole diverse, che ne costituiscono il DNA: coraggio, memoria, fiducia, dialogo, ascolto, onesta, immaginazione, empatia, amore e perdono.
Ci sono parole che oggi vengono fraintese o utilizzate in modo non corretto dai professionisti della comunicazione?
Oggi molte parole vengono abusate, più che fraintese. Entrano in un refrain ossessivo che le svuota di senso, come è accaduto con storytelling, poi diventato narrazione e infine narrativa. Lo stesso vale per resilienza, termine mutuato dalla fisica e poi adattato alla psicologia umana. Quando una parola viene ripetuta in modo ossessivo, perde il suo significato e il suo potenziale. Per questo è fondamentale riscoprire la varietà e la ricchezza della lingua italiana, senza limitarci a formule vuote o semplificate.
Chi si occupa di comunicazione dovrebbe sempre puntare a un linguaggio lineare e accessibile, ma senza rinunciare alla complessità e all’onestà. Accesso è una parola chiave: significa aprire il nostro pensiero agli altri in modo chiaro, etico e autentico. Ed è qui che entra in gioco la verifica delle fonti, uno dei principi base del giornalismo, oggi più che mai cruciale nell’epoca delle fake news. Offrire un messaggio vero e verificabile è un atto di responsabilità.
L’invito è quello di riscoprire la straordinaria ricchezza della nostra lingua e a usarla in modo consapevole, per comunicare in modo più preciso e autentico.
Spesso il linguaggio è usato per polarizzare il dibattito pubblico. Come possiamo contribuire a costruire un linguaggio più inclusivo e meno divisivo?
La polarizzazione del linguaggio è in gran parte un effetto distorto degli algoritmi delle piattaforme digitali, come Meta e X (ex Twitter), che hanno favorito la diffusione dell’odio online attraverso il meccanismo delle echo chambers. Mi spiego: noi veniamo spinti ad interagire con i nostri followers o comunque con chi, nella Community, esprime lo stesso assetto mentale e culturale, e quindi con chi ci dà più spesso dei like e si allinea di più a noi in termini di gusti e atteggiamenti.
Questi spazi chiusi che ci espongono quasi esclusivamente a chi la pensa come noi, rafforzano pregiudizi e stereotipi senza confronto né dialogo. È un fenomeno che si autoalimenta: più interagiamo con contenuti allineati alle nostre idee, più l’algoritmo ci spinge in quella direzione, riducendo la nostra apertura verso posizioni diverse.
Un esempio emblematico è quello dei terrapiattisti: un individuo scettico, entrando in una comunità online di convinti sostenitori del terrapiattismo, finirà per rafforzare il proprio pensiero a causa del bias del gruppo, il bisogno umano di essere approvati dai propri pari. Lo stesso meccanismo è alla base della diffusione dell’odio online, come dimostrano gli studi di psicologia sociale: i contenuti più polarizzati, sia positivi che negativi, sono quelli che viralizzano di più. E il negativo ha una presa ancora più immediata, perché scatena una reazione istintiva, senza passare per un’elaborazione razionale.
Ma proprio questa dinamica suggerisce anche una strategia per contrastare l’odio: lavorare sulla contronarrazione, attivando lo spettro positivo delle emozioni. L’ascolto, l’empatia e la costruzione di messaggi che uniscono anziché dividere possono ribaltare questa tendenza.
Il linguaggio istituzionale o aziendale tende a essere formale e distaccato. Credi ci sia spazio per un linguaggio più autentico anche in questi ambiti?
Assolutamente sì. Un esempio illuminante è quello di Maria Franco, la maestra che ha costruito il sistema scolastico all’interno del carcere minorile di Nisida (Napoli), protagonista, nel libro, del capitolo dedicato alla parola cura. Di fronte a ragazzi con enormi difficoltà di alfabetizzazione, non ha imposto regole grammaticali, ma ha lavorato sull’empatia, sull’ascolto e su storie in cui potessero identificarsi.
Questo dimostra il potere del racconto, un elemento fondamentale anche nella comunicazione. Il passaggio dal linguaggio dichiarativo e performativo alla narrazione è stato favorito dal digitale e dalla diffusione degli user-generated content, che hanno reso la comunicazione più partecipativa e vicina alle persone. Le aziende e le istituzioni possono trarre ispirazione da questo modello: usare storie autentiche non solo rende il linguaggio più accessibile, ma crea un legame più forte con la propria community e il proprio pubblico.
Hai menzionato nel libro il concetto di "rispettatori", una parola nuova che suggerisce un atteggiamento etico nei confronti del linguaggio e della comunicazione. Come possiamo educare alla responsabilità linguistica, soprattutto le nuove generazioni?
Nel libro ho voluto costruire un messaggio corale, coinvolgendo voci diverse per dare profondità a ogni parola. Ogni lemma è un mondo, un ponte verso altri significati, e per esplorarli ho chiesto aiuto a una giovane poetessa. Insieme abbiamo provato a immaginare un nuovo vocabolario, con parole in grado di esprimere aspetti del nostro sentire spesso trascurati.
Ne sono nate idee interessanti, come paurola, che rappresenta le parole che vorremmo dire ma che la paura del giudizio ci impedisce di pronunciare, o inequivocabolo, che invita a sciogliere gli equivoci attraverso una comunicazione più chiara e trasparente. Cyberpaura, un mix di ansia e insicurezza legate al mondo digitale, dalla privacy online all’intelligenza artificiale; infodemia: l’eccesso di informazioni che rende difficile distinguere tra notizie affidabili e fake news, amplificando confusione e incertezza.
E poi c’è rispettatore, una parola che racchiude il concetto di rispetto e ascolto. Essere un rispettatore significa porsi in un atteggiamento etico nei confronti del linguaggio: non solo attori della comunicazione, ma anche spettatori consapevoli di ciò che ci circonda. Educare le nuove generazioni alla responsabilità linguistica significa insegnare loro a usare le parole con cura, consapevoli del loro impatto e del loro potere di costruire o dividere.